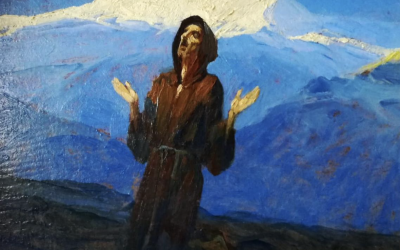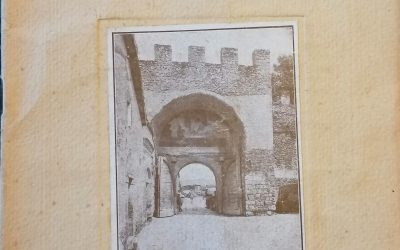Fig. 1 – Stato di Sabina
“STATO DI SABINA, FARNESE CESARINI PIO DI SAVOIA” Parte Prima
Alessandro I Farnese soleva dire di possedere tre cose sommamente belle:
il palazzo di Caprarola, la chiesa del Gesù e Clelia, sua figlia naturale, di cui andava fiero agli occhi del mondo (Moroni Dizionario V. XXIII). Personaggio tra i più potenti, fu nominato nel 1534, a soli 14 anni, cardinale dal nonno Paolo III Farnese; il padre di Alessandro I fu Pierluigi II, che il pontefice ebbe prima di dedicarsi al chiericato.
A questo punto può iniziare la narrazione.
La bellissima Clelia (Tasso e Montaigne ne tessero in particolare il fascino), nata nel 1556, fu affidata alle cure della zia Vittoria Farnese, duchessa d’Urbino ed educata in quella corte. Nel 1566, a dieci anni, fu richiamata a Roma dal cardinal padre per celebrare gli sponsalia nel Palazzo Cesarini all’Argentina, con la promessa di concedere la mano di Clelia a Giovan Giorgio, unico figlio di Giuliano Cesarini, tra i più eminenti del mondo romano e in grande ascesa, e della moglie Giulia Colonna. A Clelia veniva assicurato il buon partito dei Cesarini, che, in forte disagio per ingenti debiti, trovavano adeguato ristoro. La celebrazione delle nozze avvenne quasi cinque anni dopo, nel febbraio del 1571, con un corteo con Clelia che partì da Pesaro con destinazione Rocca Sinibalda feudo dei Cesarini, passando per Cittaducale dove fu salutata dalla zia Margherita d’Austria, figlia di Carlo V, e dalla Comunita’ di Rieti. A Rocca Sinibalda celebrò il rito nuziale il vicario generale del Vescovo di Rieti, presente la più alta rappresentanza della nobiltà romana, ma assente il cardinal padre, che gestiva con discrezione la sua Clelia per non compromettere le mire alla tiara pontificia.
Il soggiorno a Rocca Sinibalda dopo il matrimonio durò alcuni mesi, non gradito alla giovane, portata alla vita mondana, ma imposto e vigilato dal padre, la cui influenza sul genero, che già aveva perso il padre, divenne più incisiva quando, quello stesso anno, morì anche la madre. In breve gli sposi poterono tornare a Roma quando Clelia rimase incinta, ma la bambina pochi giorni dopo il battesimo morì. Nel 1572 nacque finalmente un maschio, Giuliano, che portò gioia, assicurando la discendenza ai Cesarini, pur con salute rivelatasi cagionevole.
Saltiamo un periodo non felice per la coppia, che non poté avere altri figli, ma registrò molti dissapori, fino alla morte di Giovan Giorgio nel 1585. A Clelia fu imposto dalla famiglia di sposare Marco Pio di Savoia, signore di Sassuolo nel dominio estense, e dovette quindi lasciare Roma e la sua chiacchierata relazione col cardinale Ferdinando de’ Medici per dedicarsi al governo del piccolo centro con un marito violento e spesso assente. Ma la figura di Marco Pio di Savoia riveste a questo punto maggiore interesse ai fini di questa narrazione (Treccani – Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 84 – voce Pio Marco). Nacque nel 1567, la madre Virginia, figlia di Tommaso Marino, proprietario del noto palazzo milanese che porta il suo nome, morì di peste, lasciando il cospicuo patrimonio al figlio e alla sorella Marianna, divenuta Suor Virginia Maria, futura manzoniana monaca di Monza. Il fastoso matrimonio con Clelia, il 2 agosto del 1587, avvenne nello splendido palazzo di Caprarola, caro al padre di Clelia, che lo realizzo’. L’unione fu sterile e non felice.

Fig. 2 – Parete nord particolare del ciclo pittorico della Sala delle vedute nel Castello di Spezzano proprietà del Comune di Fiorano Foto Lucio Rossi RCR Parma
“STATO DI SABINA, FARNESE CESARINI PIO DI SAVOIA” Parte Seconda
Marco Pio, di antica nobile famiglia nel territorio di Carpi, porta nel cognome aggiunto il nome dei Savoia per concessione del duca Lodovico di Savoia nel 1450 per i servigi militari resi dall’avo Alberto II. Ma ambizioso com’era si impegnò in vario modo per ottenere un titolo adeguato. Nel 1590 si recò nelle Fiandre al fianco di Alessandro Farnese, grande capitano (1549-1592), cugino della moglie. Nel 1594 si trasferì a Roma per ottenere senza esito da Giuliano Cesarini, figlio di primo letto di Clelia, il feudo di Civita Lavinia che portava l’ambito titolo ducale. Riuscì a ottenere da Giuliano nel 1595 i feudi di Stipes, Torricella e Ginestra Sabina e si trasferì a Roma per la loro amministrazione. Non soddisfatto, si arrogò il titolo di principe, ma fu intimato a desistere dal duca Alfonso II d’Este.
Dopo la morte del duca, nel 1598, il Papa Clemente VIII si riappropriò dell’antico feudo (c.d. devoluzione di Ferrara). Marco Pio si affrettò a porre omaggio, ben lieto di affrancarsi dagli Estensi, e fu accolto calorosamente dal Papa che finalmente esaudì il suo desiderio, ottenendo il titolo di Duca di Ginestra. Non ancora soddisfatto, provò anche a trattare con l’imperatore Rodolfo II per il titolo principesco che si ritenne abbia ottenuto nel 1598. Nel 1599, comunque, a Modena per affari, venne colpito da tre colpi d’archibugio e ne morì giorni dopo, rimanendo sconosciuti mandanti/esecutori.
Fig. 3 – Dettaglio di Ginestra da parete nord particolare del ciclo pittorico della Sala delle vedute nel Castello di Spezzano proprietà del Comune di Fiorano Foto Lucio Rossi RCR Parma
Clelia tornò a Roma dal figlio Giuliano, al quale sopravvisse di qualche mese, morendo nel 1613. Queste pagine di storia erano necessarie per arrivare al cartiglio “Stato di Sabina” che compare nella sala delle 56 vedute nel Castello di Spezzano, commissionate al pittore dei Farnese, Cesare Baglione, da Marco Pio di Savoia per rappresentare la consistenza del suo dominio, ricomprendenti i feudi modenesi e quelli Sabini apportati in dote nel 1595 dalla moglie Clelia Farnese. Dei castelli sabini rimangono le rappresentazioni di Ginestra e Torricella con il cartiglio del nome del feudo. Centrale anche il cartiglio Stato di Sabina. Scomparso il feudo di Stipes, per far luogo al camino a fine ‘800. Rimane aperta la necessità di indagine circa la corrispondenza del paesaggio alla realtà anche se, da alcuni documenti d’archivio, in contratti analoghi, il committente pretendeva che il pittore si recasse in situ. Complesso anche ricercare le corrispondenze con il paesaggio attuale. Sappiamo che solo dopo quattro anni, nel 1599, alla morte di Marco, Giuliano Cesarini rientra nel possesso dei feudi di Ginestra e di Torricella, di Stipes si presume la stessa vicenda. Nell’archivio del Senato della Repubblica risulta la scheda di Francesco Sforza Cesarini, casato nominato tale dal 1674, quando con Livia Cesarini, ultima erede della famiglia Cesarini, cambiò nome in Sforza Cesarini:
“Titoli nobiliari Principe di Genzano, duca di Civitalavinia, Ginestra, Segni, Torricella…signore di Stipe (Stipes).”
Fig. 4 – Dettaglio di Torricella da parete nord particolare del ciclo pittorico della Sala delle vedute nel Castello di Spezzano proprietà del Comune di Fiorano Foto Lucio Rossi RCR Parma
Nomina a senatore il 16/11/1882, deceduto il 13/6/1899. Sembrerebbe che alla detta data i feudi del c.d. Stato di Sabina siano rimasti sotto una stessa casata se pure siano venuti meno i diritti feudali. Degli affreschi fuori porta dei feudi Sabini non vi è traccia nelle varie pubblicazioni consultate, dove sono in evidenza in particolare quelli commissionati dai Mattei a Paul Bril riguardanti l’area turanense con pregiate vedute anche del castello di Rocca Sinibalda realizzato dai Cesarini, dove, come sopra ricordato, furono celebrate le nozze di Giovan Giorgio Cesarini con Clelia Farnese. Di Marco Pio di Savoia altresì non si trova menzione nelle varie pubblicazioni di storia locale che trattano i feudi ricompresi nello Stato di Sabina. Ma le scoperte sono sempre impreviste, come per gli affreschi del palazzo Orsini di Bomarzo (vedi precedente articolo sul sito) che rappresentano feudi sabini degli Orsini tra cui Colle Piccolo oggi Colle di Tora, che la Sovrintendenza ha in progetto di recuperare. Da notare che Vicino Orsini, signore di Bomarzo (1523-1585) risulta presente quando nel 1566 si stipulò il patto nuziale a Palazzo Cesarini.
Un particolare ringraziamento alla dottoressa Stefania Spaggiari, referente del Castello di Spezzano, che ha gentilmente e con tutta la competenza dato notizie sul castello e sulle vedute, fornendo documentazione e foto della vedute pubblicate nel presente articolo con la concessione dell’uso delle immagini della “parete nord, particolare del ciclo pittorico della Sala delle vedute nel Castello di Spezzano, proprietà del Comune di Fiorano. Foto Lucio Rossi RCR, Parma.
Fig. 5 – Palmeggiani Veduta di Torricella
Sommario 2022 del Territorio
Fig. 1 - San Francesco con Terminillo - Calcagnadoro. Collezione Privata.A fine anno, rileggendo i vari spunti trattati nella sezione territorio,...
Terra Sabina e Latina Gens – Parte II
La rivista Terra Sabina prende quota e pubblica con regolarità ogni mese articoli di firme autorevoli che, indagando il passato e riferendo del...
Terra Sabina e Latina Gens – Parte I
Maggio 1923, anno 1, n. 1, nasce la rivista TERRA SABINA Storia-Arte-Lettere-Agricoltura-Industria-Commercio. Non è solo una rivista del territorio,...