
Fig. 1 – Denario romano dell’89 a.C. raffigurati Tito Tazio e Il ratto delle Sabine.
Le Sabine costituirono un numeroso e scelto inizio della discendenza romana. Poche notizie ci sono state tramandate per lo più con riferimento all’episodio noto come “Il Ratto delle Sabine”.
Rimanendo alla versione prevalente del controverso episodio, secondo Plutarco furono protagoniste non meno di 800 fanciulle che parteciparono, accompagnate da parenti su invito dei romani, ai giochi in onore del dio Conso. Probabilmente si trattò di un ratto organizzato con i Sabini compiacenti e, come poi sostenuto dai romani, comprovato dal fatto che tutte le interessate erano singole, tranne Ersilia il cui nome è il solo noto pervenuto perché sembra erroneamente coinvolta, ma con buon fine in quanto molto bella e di rango andò poi sposa a Romolo.

Fig. 2 – Jacques-Louis David – Le Sabine, 1795-1798, (dettaglio di Ersilia) – Parigi, Louvre. Immagine Wikimedia Commons.
Le Sabine vennero comunemente descritte come belle e virtuose, certamente seppero gestire con saggezza e sotto la guida di Ersilia la composizione di possibili eventi cruenti, come poi numerosi artisti ne hanno ritratto il loro ruolo di risolutiva mediazione. Da Plutarco, in particolare, veniamo poi a conoscenza dell’accordo di pace intervenuto tra Romani e Sabini che dà luce alla condizione della donna Sabina cui si vollero concedere privilegi per garantire uno status in Roma analogo a quello che aveva nella patria nativa.
Il primo privilegio riguarda l’unico lavoro cui si dovevano dedicare, con esclusione di ogni altra attività, che era quello della lavorazione della lana (lanificium), importante nell’economia domestica e di rilievo sociale.
Si ricorda poi l’usanza nell’ingresso della casa coniugale sollevata dal suolo a ricordo del ratto.
Diritto di precedenza nelle strade della città.
Non si dovevano pronunciare parole indecenti in loro presenza.
Gli uomini non dovevano mostrarsi loro nudi, in caso contrario erano perseguibili come per omicidio.
Condizione quindi di particolare dignità, protette dal costume e dal diritto con riconoscimento di capacità giuridica (Eva Cantarella in varie) potevano poi partecipare a momenti di vita pubblica, pur accompagnate dai loro uomini. Tutto ciò fa intendere che le future madri dei romani erano già portatrici di uno status alto che faceva riferimento ai valori e alle tradizioni Sabine e ad una apprezzata severa educazione.
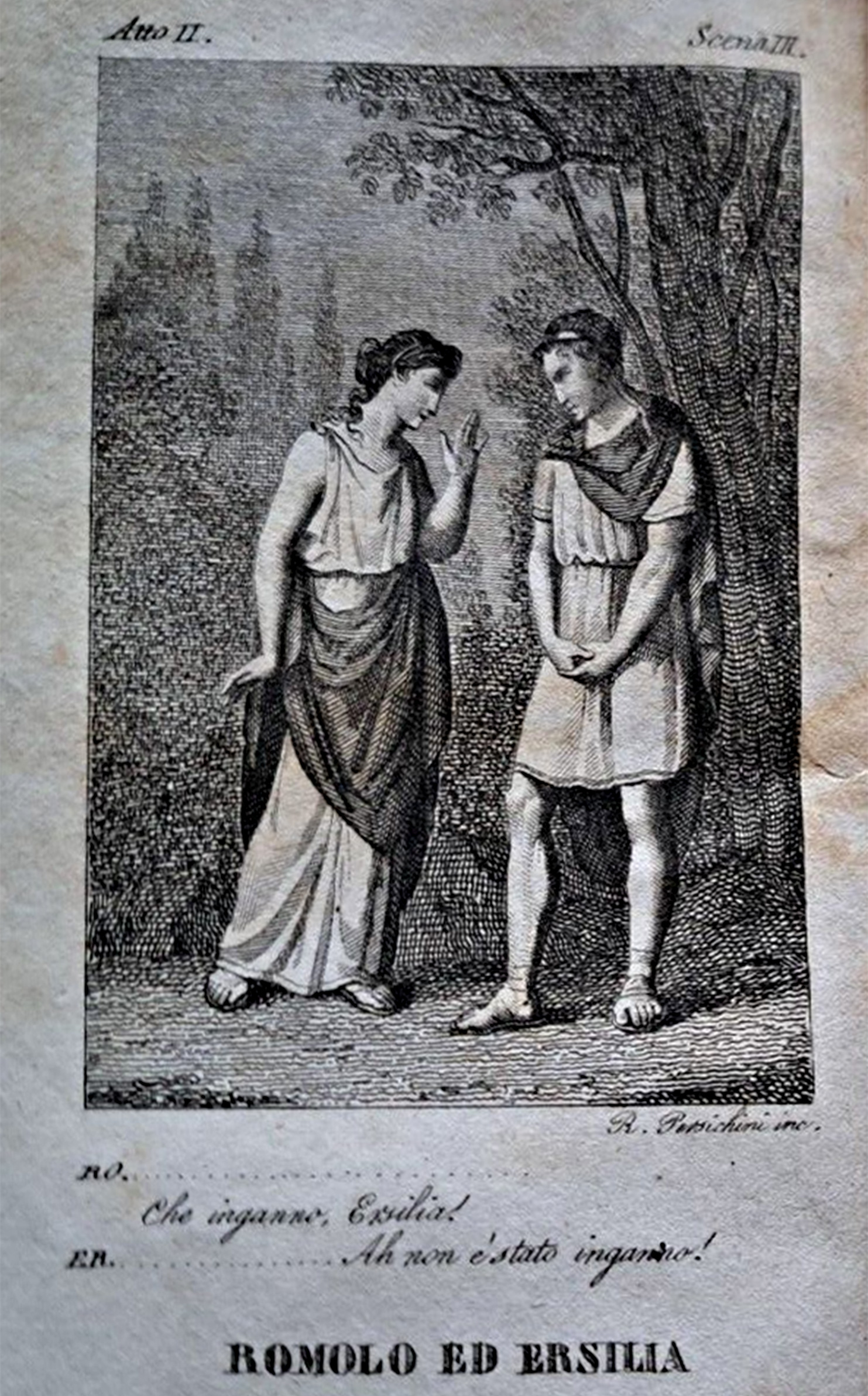
Fig. 3 – Roma 1837. Incisione per un’opera melodrammatica su Romolo ed Ersilia, Pietro Metastasio.
Di conseguenza le famiglie costituite con i Romani ebbero l’apporto fondante di tale patrimonio culturale, analogamente si può immaginare avvenne con le primavere sacre (Ver Sacrum) che dettero origine a comunità nelle quali i giovani sacrani sabini provvidero a diffondere il loro patrimonio culturale (religione, diritto, costumi) con il latte materno.
Una così pregnante dotazione identitaria lascia pensare che non si sia granché intaccata nel tempo, mantenendo, seppure inconsapevolmente, la connotazione di fondo. Quasi a riprova sono molte le accademie che il Collegio Sabino in Roma tenne per celebrare il Natale di Roma nell’800 che esaltavano le Sabine madri dei romani, sottolineando come la loro virtù si accompagnava al piacente aspetto e non di rado sottolineando che ancora oggi le donne Sabine onoravano le loro ave “di bellezza ornate e di virtù”.
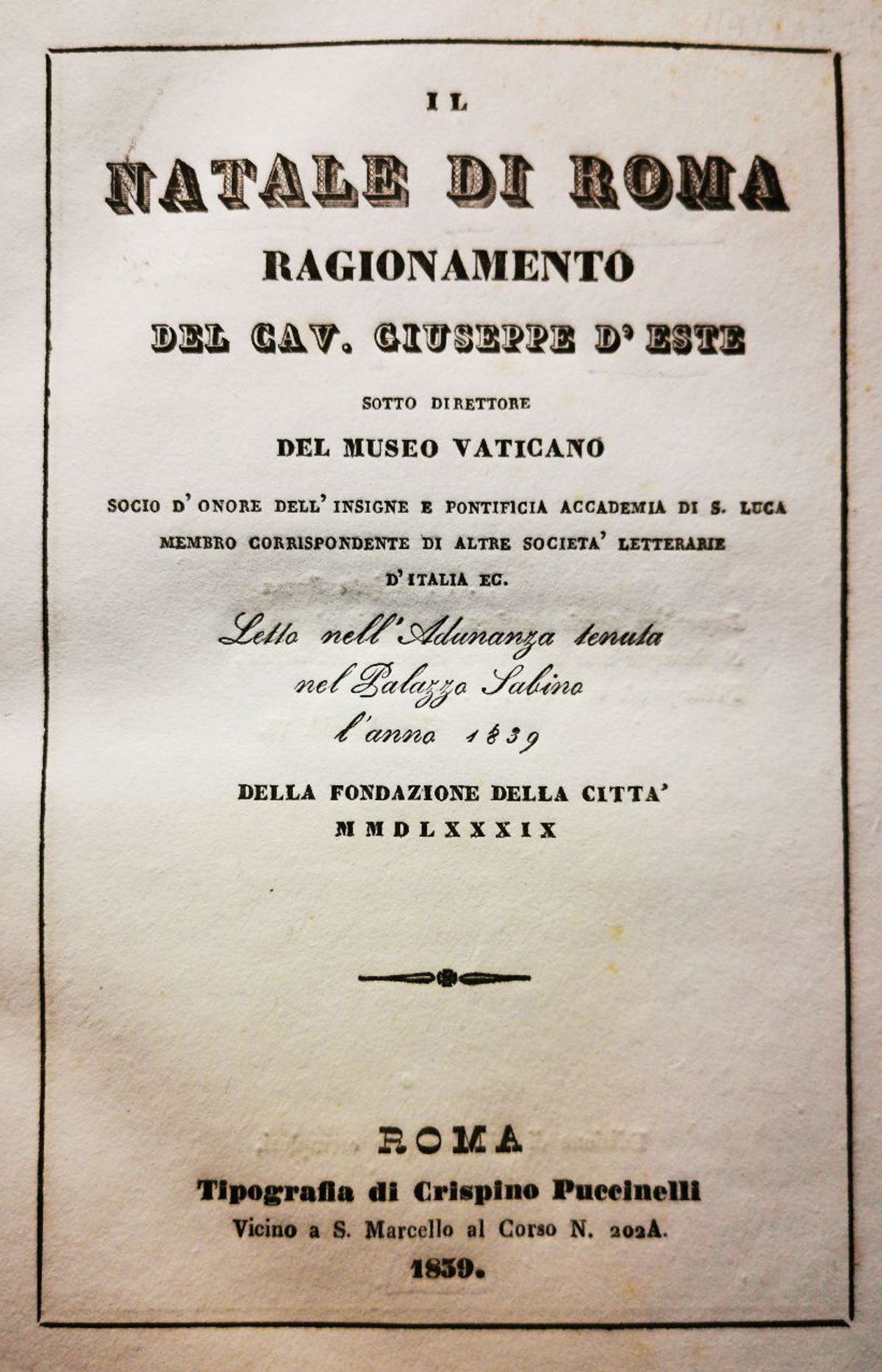
Fig. 4 – Puccinelli, Roma 1839. Il Natale di Roma, ragionamento del Cav. Giuseppe D’Este.
In occasione delle nozze Pecci-Vincenti Mareri una rivelazione giornalistica dall’Osservatore Romano, 20 febbraio 1886, al di là dell’attenzione alla cerimonia dell’organo pontificio (sul soglio c’è Leone XIII, Papa Pecci, zio dello sposo), ci regala un’importante e preziosa informazione che si riporta:
“Quando nell’ottobre 1883 inauguravasi la linea ferroviaria Terni-Rieti-Aquila, i rappresentanti della stampa, che qui fecero breve sosta, notarono la speciale avvenenza delle donne di Rieti e seguendo un vezzo del tempo, nei rispettivi giornali ebbero per esse lusinghiere parole. Grato per la cortesia di quei giornalisti, io oso inoltre affermare che più delle forme esteriori sono le doti dell’animo che rendono in tanta parte amabile il gentil sesso del nostro paese; sono le convenzioni religiose, la schietta indole, i modi corretti che han provocato a suo favore la stima così dei cittadini come degli estranei”.
E l’elogio prosegue doviziosamente delineando un profilo che non è difficile immaginare risalente nel tempo e presente nei luoghi di riferimento.
Altre tracce sul tema le ritroviamo nel libro “Versi” (Trinchi Rieti, 1900) dell’illustre reatino canonico Don Vincenzo Boschi, cultore di cose sabine la cui collezione di reperti archeologici è oggi esposta al museo comunale della città di Rieti. Nel “Sonetto sopra una giovanetta” (maggio 1899), dopo averne lodato le grazie
“modesta in atto, un lampeggiar divino
a lei dall’occhio ceruleo, sfuggio”
concludeva
“de le Agnesi qui l’aura ancor si sente”.
È pregnante il riferimento alla santa martire che originava da antica famiglia sabina.

Fig. 5 – Stato Pontificio. Costume di Rieti. XIX sec. Collezione privata.
Venendo all’oggi, il punto sulle donne sabine sarebbe stata impresa di tutta arbitrarietà, venuti anche meno riferimenti territoriali ufficiali, tutt’al più supponendo memorie locali persistenti tali da far ancora considerarsi in qualche modo sabino.
E accade di venire a conoscenza di una locandina relativa a una mostra fotografica dal titolo sorprendente per inerenza “LE SABINE BELLEZZA E RIBELLIONE” che si è tenuta a Monteflavio nel 2019 a cura della storica dell’arte Livia Granati, valente e affermata fotografa professionale. La stessa ha informato che la mostra ha visto come protagoniste le donne sabine (rappresentate da 8 foto ritratto di donne di diverse età, tutte originarie della Sabina romana) in riferimento ad un’opera d’arte storica, ovvero il ratto delle sabine di Jacques Louis David.
Il tema principe però, non era tanto il ratto, quanto proprio la bellezza delle donne sabine: bellezza fisica e bellezza interiore, dettata dalla forza e l’audacia che le contraddistingueva. Una storia che Livia Granati, in quanto Sabina doc, sente sulla sua pelle, e per questo ha deciso di partire proprio dal simbolico soggetto del mitico ratto, per spiegare il suo credo fotografico.
Un ulteriore approfondimento sulla mostra è disponibile a questo link: https://www.italiasera.it/livia-granati-le-sabine-donne-di-razza/

Fig. 6 – Monteflavio 2019. Locandina della mostra “Le Sabine. Bellezza e ribellione”. Per gentile concessione dell’artista.
Archeologia pubblica nella Valle del Turano: evento di presentazione del 7 luglio 2025
Figura 1 - Locandina eventoIl primo riconoscimento al merito di questa iniziativa è certamente l'importante partecipazione, nonostante il diluvio...
Sabini nel tempo – Pulchra Sabina Preces Prisca Chirurgis Patria
Figura 1 - Carta tratta da Italia Antiqua di Filippo Cluverio, 1624Leggere dei tempi antichi da testi di studiosi di secoli trascorsi può dare,...
Tersilio Leggio lo ricorda Roberto Marinelli
Tersilio Leggio visto da Roberto Marinelli 2002Un vuoto incolmabile, lo ricorda Roberto Marinelli che con lui ha contribuito a farci conoscere e...



